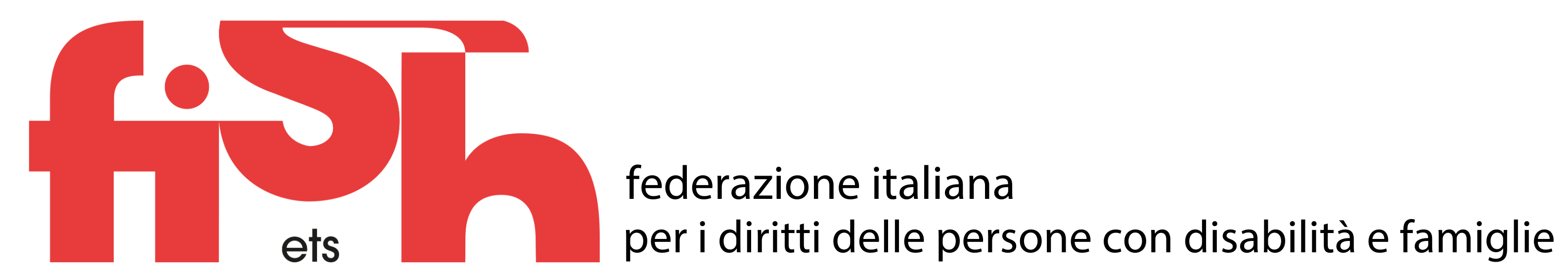In occasione della decima Giornata nazionale del malato oncologico, è stato presentato a Roma il 7° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici.
Il Rapporto, prodotto annualmente dal 2009, è frutto dell’Osservatorio permanente sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, composto da: il sistema delle Associazioni del volontariato oncologico attraverso la FAVO, il CENSIS, l’Associazione Italiana degli Oncologi Medici (AIOM), l’Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO), la Società Italiana di Ematologia (SIE), Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT), Federsanità-ANCI, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG), la Società Italiana di Psico Oncologia (SIPO), la Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO), l’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), il Coordinamento Generale Medico-Legale dell’INPS e la Direzione generale del Sistema informativo del Ministero della Salute.
Secondo lo studio di AIRTUM, ampiamente commentato all’interno del Rapporto, nel 2010 erano 2.587.347 le persone che vivevano in Italia dopo una diagnosi di tumore, il 4,4% della popolazione residente. I pazienti con un’attesa di vita paragonabile a quella delle persone non affette da tumore erano 704.648, pari al 27% di tutti i pazienti e all’1,2% degli italiani. Complessivamente, quindi, un malato di cancro su quattro poteva considerarsi guarito a tutti gli effetti.
Nel 2015 si stima siano circa 3 milioni (3.036.741), in Italia, le persone vive dopo una diagnosi di tumore, con un incremento, rispetto al 2010, del 17% (20% per gli uomini e 15% per le donne).
Lo sviluppo di cure più efficaci ha consentito un aumento del numero dei pazienti che sopravvivono alla malattia. Oggi un paziente su quattro guarisce. Emergono, quindi, nuovi bisogni di “riabilitazione” fisica, psichica, lavorativa e sociale. E, al contempo, la necessità di una razionalizzazione delle spese sanitarie spinge sempre più verso l’ospedalizzazione breve e l’assistenza domiciliare. A fronte di tali considerazioni, il Rapporto mette in luce come la ricaduta economica e sociale nella cura dei malati oncologici abbia assunto dimensioni considerevoli, con conseguenze importanti sia sulle famiglie, fonte primaria di sostegno, sia sul sistema di welfare del nostro Paese.
Nel 2014 si stima siano stati diagnosticati circa 365.500 casi di tumore maligno (1.000 casi al giorno). E le patologie neoplastiche hanno rappresentato la principale causa di riconoscimento sia dell’assegno ordinario di invalidità che della pensione di inabilità, con un trend in costante crescita nel corso degli ultimi anni.
Se gli effetti delle patologie tumorali sono molteplici e coinvolgono una pluralità di dimensioni di vita per le persone e le comunità, anche i costi che queste producono sono molteplici e articolati. Essi vanno da quelli prettamente sanitari a quelli di carattere socio-economico, legati ad esempio agli impatti sulla vita lavorativa e sulla capacità di produrre reddito, fino ai costi intangibili di tipo psicologico e umano, che riguardano non solo i pazienti ma anche i caregiver, familiari o meno.
Emerge, quindi, chiaramente la necessità di un aumento dei servizi sociosanitari e l’esigenza di offrire a tutte le persone colpite da patologie oncologiche un aiuto concreto per affrontare nel migliore dei modi non solo la gestione della malattia, ma anche la “ripresa di vita”, riducendo le complesse difficoltà cui va incontro tutto il sistema familiare.
Calcolare i costi sociali ed economici delle patologie è tuttavia un processo complesso, e non solo per il suo carattere multidimensionale, ma anche perché una parte dei dati necessari non risulta facilmente reperibile tramite fonti ufficiali e richiede la realizzazione di indagini e rilevazione ad hoc. Un tentativo in tale direzione era stato fatto nel 4° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, pubblicato nel 2012, in cui veniva stimato il complesso dei costi sociali ascrivibili alle malattie oncologiche sostenuti dalle famiglie, calcolato come risultante di costi diversificati. Alcuni diretti, di tipo medico (per visite specialistiche, farmaci, ecc.) e non medico (trasporti, ecc.). Altri indiretti, fatti di redditi da lavoro mancati, ma anche e soprattutto di servizi di cura prestati dai caregiver, in particolare mogli, conviventi, sorelle e madri.
Per maggiori approfondimenti consultare i nostri Focus sul Lavoro di cura e su Colf e badanti.